|
Dagli anni Cinquanta ad oggi (1951-2011)
Dagli anni Cinquanta ad oggi (1951-2011)
Seleziona una lettera:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Gli articoli più visualizzati
geografia dell'Italia Cronologia
Italia prima e dopo l'Unità Garibaldi italia preunitaria Parole suoni ed immagini inno Giuseppe Mazzini I movimenti, i valori, i libri L'Italia negli anni del Risorgimento La memoria e le interpretazioni del Risorgimento Viaggi nel Risorgimento Cavour Antologia di poesie 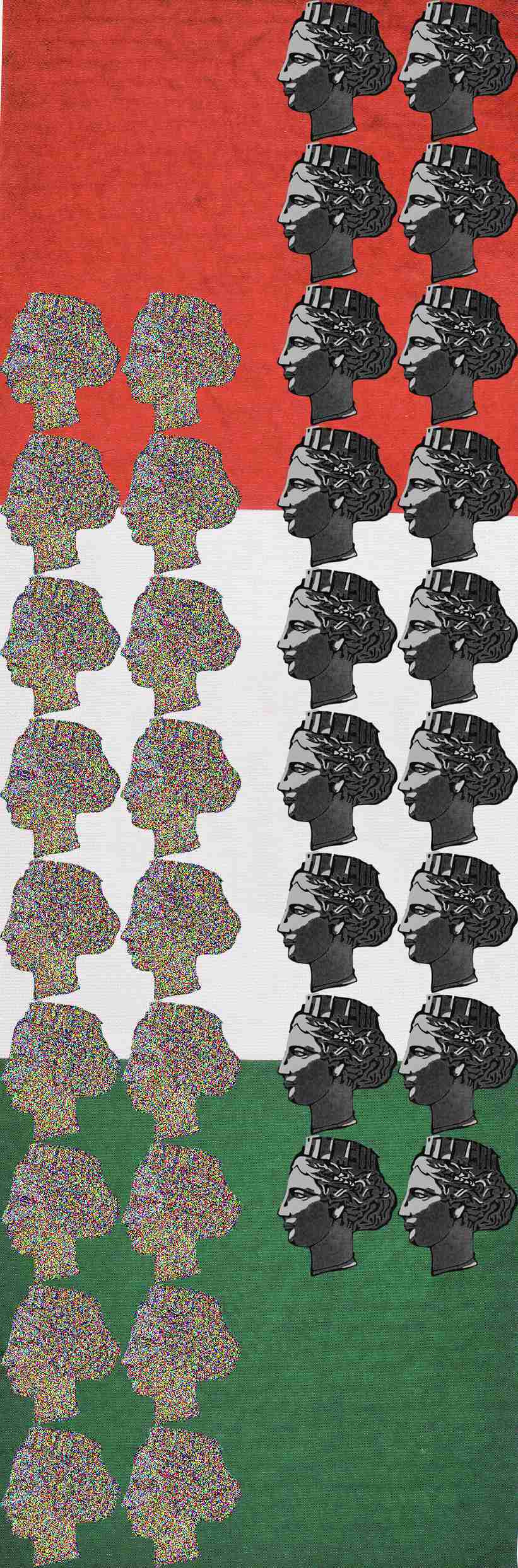
Sito ottimizzato
Sito ottimizzato per una risoluzione di 1024x768px o superiori.
|
Nella biografia scritta da Alain Elkann, Alberto Moravia confessa: «Sì, ci furono dei giorni in cui avrei desiderato ucciderla». Parla, naturalmente, di Elsa Morante, sua moglie, con cui visse per 25 anni e da cui, anche dopo la separazione, non divorziò mai. Ufficialmente fu lei a non voler rompere il matrimonio, per motivi di fede religiosa; ma è lecito dubitare che quel rapporto «così stretto, così complesso e in fondo così vivo» da far apparire il delitto «più facile della separazione» (è sempre Moravia a parlare), fosse per entrambi una catena virtuale, una simbiosi a distanza che lui subiva con una certa rassegnata noncuranza, e in cui lei si dibatteva con dolorosa e contraddittoria visceralità. Perché per Elsa, come nota acutamente Edda e Carlo Sgorlon (Cahiers Elsa Morante, a cura di Tjuna Notarbartolo e Jean-Noël Schifano), l'amore non è mai un rapporto libero tra pari, ma «un rapporto tra schiavo e padrona, o viceversa, paurosamente possessivo e feudale». Tra gli amanti, c'è chi viene idolatrato e chi si prosterna, non certo in ossequio all'antica regola amorosa che premia chi fugge, piuttosto per una profonda estraneità della scrittrice ai principi di eguaglianza, anche di quella tra i sessi, imposti dalla modernità. Scrive ancora Sgorlon: «La Morante sembra idealmente appartenere a un mondo prerivoluzionario, feudale, in cui non esistono cittadini di pari grado e dignità, regolati da leggi democratiche, ma soltanto patrizi e plebei, feudatari e servi della gleba. Nel mondo astorico della sua narrativa la democrazia non esiste, né come struttura storica, né come mentalità». I legami d'amore e d'amicizia non potevano dunque che essere tormentati, vissuti nella polvere o sugli altari, adorando o umiliando l'oggetto di passione, innalzandolo o schiacciandolo con furia. Alberto Moravia, scrittore aureolato di successo e di fortuna, inafferrabile per una sua maschile ritrosia al possesso, rimase sempre per la moglie una sfida irrisolta, una partita interrotta, mai sanata da una vera pacificazione. Elsa nasce a Roma il 18 agosto 1912. La madre, Irma Poggibonsi, è ebrea, maestra elementare come la Ida Ramundo della Storia; il padre, quello vero, è Francesco Lo Monaco, padre anche dei figli che seguiranno (Aldo, Marcello, Maria; il primogenito, Mario, muore neonato). Augusto Morante, il marito di Irma, che lavora in un riformatorio per minorenni, ai figli ha dato solo il cognome. Su questa ambigua situazione la scrittrice ha alzato, con una frase piena di pudore, una barricata difensiva: «Mia madre è stata la più casta delle donne». Essendo un po' anemica («la mia faccia era pallida come quella di una bambola lavata, e i miei occhi celesti erano cerchiati di nero») a sei anni va a vivere presso la sua madrina, «che aveva per sua sorte favolosa sposato un conte ricchissimo». Nella bella villa di Donna Maria Guerrieri Gonzaga Maraini la piccola Elsa sviluppa un rapporto di amore e odio, di umiliata ammirazione, per quelli che lei chiama “i patrizi”. E anni dopo, per descrivere gli effetti di quella convivenza sulla sua anima bambina, dirà: «L'anima mia era una cosa grossa e nera, piena di occhi curiosi e di tortuosi, cupi vicoli. Era un mostro ipocrita e spietato». Dopo il liceo classico, Elsa si iscrive all'università, che interromperà presto, e va a vivere da sola. Si mantiene con una furiosa attività di scribacchina: scrive, scrive indefessamente, come del resto ha fatto fin da piccola, articoli, racconti, fiabe, tesi di laurea. Nel ‘36 incontra Alberto Moravia, e l'anno successivo ha inizio la loro lunga storia: dopo una serata al ristorante con amici, lei lo saluta mettendogli nelle mani le proprie chiavi di casa. E un gesto forte, una consegna di sé; ma l'amore di Moravia non corrisponderà mai ai desideri totalizzanti di Elsa. «Non ero innamorato, ma affascinato da qualcosa di estremo, di straziante, di passionale che c'era nel suo carattere. [... ] Diciamo la verità, io non provavo un violento desiderio per lei». Elsa aveva allora un corpo slanciato ed elegante, e una faccetta piena, dal broncio un po' infantile, sotto una massa di capelli precocemente imbiancati. Giulia Massari riporta un giudizio di Carlo Levi, che la va a trovare quando ancora abita sola, a Via del Corso: «Non era una donna. Con quegli occhi viola, quella faccia piccola e larga, il sorriso timido che scopriva i denti minuti, separati, e i capelli grigi, arruffati disordinatamente». Eppure, in modo selvatico e pieno di grazia ombrosa, la Morante era bella. Antonio Debenedetti la ricorda, anzi, bellissima: «Ero un ragazzo, ed ero molto affascinato da Elsa come donna. E proprio per questo, negli anni in cui Elsa era malata, durante la sua lunga agonia, io non guardavo mai le sue foto sui giornali. Avevo l'immagine di una donna bellissima, e non volevo coprirla con l'altra immagine, quella di una donna vecchia e malata». Lei non si sentiva bella: «Fu mai proprio bella, EM? No, mai. [... ] Queste erano le sue amarezze, fin da bambina, ma gli altri, nonostante questi difetti, la giudicavano graziosa e bella. Di più, essa voleva essere un grande poeta. E tutto questo perché? Per essere molto amata. Nessuno l'amò mai». Il matrimonio con Moravia, celebrato con rito religioso nel ‘41, la mette al riparo dal bisogno; e infatti, da quella data la Morante di colpo smette di scrivere per giornali e riviste, e si abbandona con intensità quasi esclusiva alla sua vocazione di romanziere. In un'intervista, confesserà: «Io volevo scrivere l'ultimo romanzo possibile, l'ultimo romanzo della terra». Per Alfonso Berardinelli si tratta di una «evocazione magica, stregonesca, dell'idea, dell'archetipo del Romanzo», di una devozione religiosa, o venerazione idolatrica, per il romanzo come «forma a priori, forma simbolica, ordinatrice dell'esperienza nella sua globalità». Il romanzo viene paragonato a una cattedrale, anzi, all'immagine onirica di una cattedrale. Dall'edificazione di queste grandiose architetture narrative passa la rivincita della realtà immaginaria contro “l'irrealtà” storica. La realtà, per Elsa Morante, è fondamentalmente inconoscibile, se non attraverso la verità poetica, la visione oracolare e profetica dell'artista: «E mai, come nei periodi di dittatura scientifico industriale, si richiede ai poeti di difendere la loro verità, come un feudo minacciato, che appartiene a loro, ma è un bene necessario per tutti». Il compito dello scrittore si confonde con quello del narratore di miti e del fondatore di civiltà, e anche con quello dell'archeologo che cerca il tesoro nascosto. Scrivere vuol dire porsi come mediazione tra il lettore e la verità, inattingibile con i poveri strumenti della ragione; e il lettore predestinato e impossibile della Morante è infatti l'analfabeta, a cui va la famosa dedica della Storia: «Por el analfabeto a quien escribo». Nei romanzi, il mondo sentimentale barbarico e premoderno della scrittrice si espande, si popola, si apre su fondali magnifici e favolosi; le ombre familiari di Menzogna e sortilegio, l'isola magica dell'adolescente Arturo, la strage di innocenti perseguita dalla storia, la ricerca delle radici materne in Aracoeli. Ma il tema che torna, sotterraneo e centrale, di libro in libro, è quello della maternità. Nessuno, più della Morante, è penetrato in quel viluppo di sentimenti esaltati e straziati, in quel l'intrico amoroso di possesso carnale e di squisito abbandono che unisce madre e figlio (Cesare Garboli parla di «tema androgino, ermafrodito»). Da figlia, lei che mai è stata madre, ha svelato con teatralità qual è l'unica perfetta felicità concessa in terra agli umani, la beatitudine fusionale in cui ci culliamo, bambini, prima di sapere che siamo soli, smarriti nel mondo. Da quella breve parentesi di felicità ignara scaturisce anche tutto il nero, l'ostinata ricerca di quell'ora perduta e sempre reinventata, il dolore del sé, l'orrore dello specchio che ci rimanda un'immagine solitaria, vile e inadeguata perché mai abbastanza amata; e il desiderio insaziato che si nutre di illusioni, di menzogne, rifiutando la miseria del reale. Menzogna e sortilegio, sorprendente romanzo che pare nato antico, incollocabile per la critica (uscì nel ‘48, in pieno neorealismo) è la saga di una famiglia piccolo-borghese i cui furori snobistici slittano dal travisamento consapevole dei fatti, fino alla inconsapevole follia. Edoardo, il cugino nobile, di irresistibile e capriccio sa bellezza, il cui destino è la morte precoce, è una di quelle figure maschili morantiane dal fascino efebico, che non si possono raggiungere, per cui si può solo spasimare in solitudine. Con la sua capacità di riempire di sé i propri libri senza mai raccontarsi direttamente, la Morante ha adombrato in questi personaggi la sua identificazione impossibile con il “fanciullo divino”, e i suoi impossibili innamoramenti per Luchino Visconti o l'artista americano Bill Morrow. A lungo Elsa subì una doppia e opposta attrazione per una femminilità primitiva, puerile e materna, portatrice di forme arcaiche di inculturazione e di civiltà, e la grazia leggera, acerba e libera (libera dalla schiavitù tutta femminile del corpo) dei giovani maschi, adolescenti o poco più, di ambigua leggiadria. Il culmine felice di questa duplice fascinazione è segnato dall'Isola di Arturo, con cui, nel ‘57 vince il Premio Strega. L'isola è un radioso punto di equilibrio, oltre il quale il mondo narrativo morantiano si incrina e si scompone, conosce il degrado di un'età adulta che può essere solo dolorosa, perché, come è scritto nella Dedica iniziale, «fuori del limbo non v'è eliso». Nel 1962 Bill Morrow muore precipitando dalla finestra di un grattacielo di New York, Alberto Moravia va a vivere con Dacia Maraini, ed Elsa compie cinquant'anni. La tragedia, l'improvvisa solitudine, l'incombente maturità, aprono un processo che Cesare Garboli ha descritto con illuminante acutezza in un saggio ripubblicato nella raccolta Il gioco segreto: «Elsa cominciò allora, o subito dopo, a cambiare, subendo una metamorfosi anche fisica. Sembrava invasa da una forza estranea al suo corpo e contraria, ostile anche alla sua anima. [... ] Si può invecchiare restando uguali o simili a se stessi; ma Elsa non ebbe questo non so se privilegio o destino comune: diventò un'altra persona; e smarrì, o uccise in sé, la gioia della sua grazia». Già nel Mondo salvato dai ragazzini, che esce nel fatidico ‘68, in empatica (ma distante) coincidenza con l'utopia sovversiva degli studenti, circola, anche nell'apparente levità di alcuni tra i testi che compongono il volume, un'aria amara. I ragazzini chiamati a salvare il mondo sono i “Felici Pochi”, innocenti di pasoliniana inconsapevolezza (o forse è vero il contrario, sono i ragazzi di Pasolini ad avere, qui e là, tratti morantiani). Sono coloro a cui l'eterna adolescenza, la semplicità d'animo, negano ogni possibile realismo d'accatto, ogni mercimonio con il potere, coloro il cui sguardo resta sempre capace di incanto. È questa la natura anche dei protagonisti-vittime della Storia, che esce nel ‘74. Anche questo romanzo viene pubblicato, come tutti gli altri, da Einaudi, ma subito nella collana economica «Gli struzzi». E l'autrice a volere fortemente che il libro non segua il solito percorso editoriale, ma si ponga con immediatezza come un'azione politica, uno squillo di tromba, un appello diretto ai lettori. Ne segue un diffuso malinteso interpretativo per cui, come scrive ancora Garboli, «la figura e la persona della Morante si è venuta fissando nello stereotipo del grande narratore morale, con tratti di maestà ed autorevolezza quasi di maestro e di vate, infagottato in lane e scialli da contadina». A delineare questa immagine contribuisce il ritratto abbozzato da Pasolini, ma soprattutto l'idea del pubblico, che ormai riconosce nella scrittrice colei che ha denunciato «lo scandalo che dura da diecimila anni», la storia. In realtà il libro non parla di storia ma di natura; non di responsabilità ma di inconsapevolezza. La potenza materna regredisce rispetto al romanzo precedente, diventa una qualità che appartiene con più pienezza alla protettiva cagna Bella che alla spaurita Ida; lo scandalo è l'assenza di pietà che distrugge le relazioni naturali, e che è insito nella costituzione di ogni potere. Il libro, mal digerito dalla critica, diventa, col suo enorme successo, un caso editoriale, oggetto di accese discussioni politiche forse più che letterarie. Siamo nel pieno degli anni Settanta: gli intellettuali marxisti, pochissimo convinti, storcono il naso, ma i lettori si commuovono, partecipano, se ne infischiano della correttezza ideologica della Morante, e scrivono alle redazioni dei quotidiani più politicizzati accorate lettere in sostegno dell'amato romanzo. Intanto, la Morante, dopo un breve viaggio in Andalusia, comincia a scrivere Aracoeli. Una sera del 1980, mentre è a cena con alcuni amici, cade e si rompe il femore. Il processo che stravolge e mina il fisico della scrittrice ha un punto di non ritorno: da questo momento si trascinerà da una clinica a un'altra, con brevi e tal volta insostenibili ritorni a casa, tra ricadute ed effimeri momenti di ripresa, operazioni chirurgiche e cure mediche. Due anni dopo cerca di uccidersi con il gas e i barbiturici, oppressa dall'invalidità che la costringe a letto e le rende penosi più semplici gesti quotidiani; la salva, con sensitivo tempismo, la domestica, Lucia Mansi («È veramente un angelo. Il suo unico difetto è quello di arrivare sempre in ritardo. Un solo giorno è arrivata in anticipo... »). Elsa passerà i suoi ultimi anni in una clinica romana, vivendo, sempre secondo Garboli, «come se fosse un'altra persona, irriconoscibile per chi l'avesse frequentata anche solo un po' intimamente nel passato: sparite le collere, le dolcezze, le battaglie; sparita la sua eterna discussione col mondo». In questo atteggiamento di consapevole abbandono la coglie la morte, in un giorno di novembre del 1985. Nell'‘82, l'anno del suo tentato suicidio, era uscito anche il suo ultimo romanzo. Sembra che i temi più cari alla scrittrice, la femminilità selvatica e primitiva, l'intimo splendore della maternità, il fascino della sessualità ambigua e incerta dei maschi adolescenti, siano sottoposti a revisione spietata, e riproposti in versione grottesca e corrosa dal degrado. L'irrealtà storica ha invaso ogni sogno edenico, ogni nostalgia delle origini. Nulla si salva, nemmeno l'isola della giovinezza e dell'innocenza, “l'iso-letta celeste” in cui Nunziata e Arturo sarebbero rimasti immuni dalle insidie del tempo e della storia. Aracoeli, la madre andalusa che affoga nelle domande impazzite del corpo, murata nella carnalità senza luce, e Manuel, il figlio omosessuale legato a tutti gli impacci umilianti della mancanza di grazia e di bellezza, sono la caricatura amara delle coppie madre-figlio dei romanzi precedenti. La maturità, per la Morante, è un peccato senza redenzione, che raggiunge quasi ogni essere umano, e che non ha nessuna connotazione positiva. I Felici Pochi, infatti, sono morti giovani, o anche nell'estrema vecchiezza sono riusciti senza sforzo alcuno a mantenere un'anima infantile, uno sguardo di irriducibile candore. La maturità che porta a patteggiamenti col reale, a saggi compromessi col mondo, è solo un abbaglio da Infelici Molti. A Manuel che, in un dialogo immaginario con la madre, lamenta lo scacco dell'intelligenza («L'intelligenza si dà per capire. E a me si è data, ma io non capisco niente. E non ho mai capito e non capirò mai niente») l'ombra di Aracoeli, con un riso tenero, risponde: «Ma, niño mio chiquito, non c'è niente da capire». Eugenia Roccella |
||||||






 Tutti i diritti riservati - Copyright MMX -
Tutti i diritti riservati - Copyright MMX -